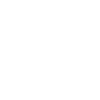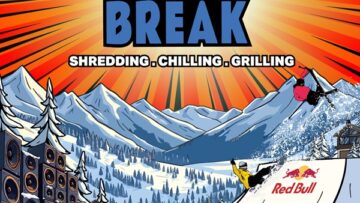Sci alpino e apprendimenti: dall’approccio esecutivo al modello interpretativo
di Enrico Clementi
Lo sci alpino, come altri sport, è un apprendimento. Ha, in altri termini, le caratteristiche di un’attività che genera delle modificazioni comportamentali – più o meno evidenti, più o meno apprezzabili – conseguenti o indotti dall’interazione con l’ambiente e da nuove esperienze.
Possiamo dire che ad oggi, nello sci alpino, permane, rispetto al modo d’intendere questo apprendimento, una divisione abbastanza chiara, che ha ricadute sia sul metodo, che sul “tipo” di sciatore prodotto.
Abbiamo quindi da un lato un approccio che potremmo definire “comportamentista”, che fa leva sull’aspetto esecutivo, sulla ripetizione, sull’acquisizione di automatismi: secondo questo approccio meccanicistico, sequenziale, vi è un principio associativo diretto tra stimolo e risposta che sarebbe alla base dell’apprendimento.
Dall’altro un approccio d’impronta “cognitivista”, che non si limitano a considerare la modificazione del comportamento e il meccanismo associativo come condizione essenziale per l’apprendimento, ma è orientato a produrre la creazione di rappresentazioni mentali che medino il rapporto tra lo stimolo e la risposta: l’atleta migliora, apprende, perché è in grado di crearsi delle rappresentazioni mentali della situazione, e sulla base di queste agisce in modo conseguente.
Abbiamo, quindi, sul piano del metodo, due approcci, il primo dei quali assolutamente diffuso e che produce, nella migliore delle ipotesi e senza nulla togliere a questa abilità, dei buoni o degli ottimi “esecutori”; il secondo degli sciatori o degli atleti “interpreti”, che si avvalgono di un processo di apprendimento caratterizzato da soluzioni che sembrano prospettarsi in modo inatteso in una situazione di stallo/difficoltà (insight).
Sono, questi secondi, degli atleti che hanno maturato una profonda consapevolezza dei propri sentimenti, delle proprie emozioni, e dei moventi del proprio comportamento; ma anche atleti che imparano dall’osservazione dei comportamenti altrui, derivando da tale osservazione una sorta di “rinforzo vicario”, nei modi dell’apprendimento imitativo. Che, lo precisiamo, è diverso da quello emulativo, che è tipico invece dell’apprendimento di quello che abbiamo chiamato “sciatore esecutore”.
Il modo d’apprendere dello “sciatore interprete” è in gran parte caratterizzato da processi di apprendimento latente, implicito, informale, situato, continuo, nei modi dell’apprendimento dinamico (o culturale). E la pratica che ne deriva è una pratica chiamata “deliberata” (deliberate practice), dove apprendimento e perfomance sono trattate in modo diverso e funzionale l’una all’altra: l’atleta non è sempre in “modalità performance”, ma conosce tempi e contesti d’apprendimento programmato e variamente finalizzato.
Non intendo creare una divisione netta tra uno sciatore “esecutore” e “interprete”, né una divisione netta tra metodologie d’impronta comportamentista, e altre cognitivista, ma comunque rendere evidenti le differenze tra le due, e l’opportunità, a seconda delle fasi d’apprendimento e delle caratteristiche dell’atleta, di scegliere tra:
-
un apprendimento legato a un cambiamento nella configurazione di stimoli (o al presentarsi di nuovi problemi);
-
un apprendimento legato all’esperienza di un’esposizione continuativa alla stessa configurazione di stimoli, nei modi tipici dell’allenamento attuale.
Fa riflettere che anche per l’alto livello l’allenamento tipico, almeno nelle nostre squadre nazionali, sia di questo secondo tipo; come se s’intendesse rafforzare le abilità esecutive dei nostri atleti, piuttosto che implementare gli apprendimenti.
Già Piaget indicava che l’apprendimento è un processo che ha senso solo in situazioni di cambiamento. Per questo motivo, imparare è in parte sapersi adattare a queste novità, tramite processi di assimilazione e accomodamento; favorendo inoltre l’emergere di risorse personali e soluzioni non note, e non necessariamente coscienti, se non a posteriori.
È importante sottolineare quest’ultimo aspetto, ossia che l’apprendimento, diversamente da come si ritiene, non è necessariamente intenzionale, ma “accidentale”; a condizione però che vi sia esposizione a stimoli diversi o diversamente configurati, e ci si esponga all’errore e – almeno provvisoriamente – all’assenza di indicazioni, spiegazioni, risposte.
In questo senso l’allenatore è un tutor, un (ri)orientatore dell’esperienza, un osservatore partecipe, un ascoltatore attivo che demanda all’atleta la soluzione dei problemi, ma ne facilita la lettura, l’elaborazione, e suggerisce strategie di cambiamento: si assume la responsabilità di “rompere equilibri” – in specie in assenza di risultati o in presenza di discontinuità di risultati – anziché rafforzarli, sostenendo con l’atleta il disagio che questo comporta.
Si potrebbe obiettare che lo sci alpino, in quanto sport di situazione, rispetto a sport a schema “chiuso” (ammesso ve ne siano realmente), sottopone l’atleta evoluto o il giovane atleta a un processo di costante adattamento a situazioni nuove, e quindi a un costante processo di assimilazione.
È assolutamente vero, ma ci sono vari aspetti da considerare, al fine di potenziare una caratteristica implicita dello sci alpino, della quale non abbiamo alcun merito, e che l’approccio tecnico federale, se non giustamente compreso e collocato, tende a vanificare. In specie là dove ripreso e riproposto in ambiente agonistico giovanile e appunto in chiave emulativa.
Il rischio reale è quello che una scuola sci nazionale riconosciuta di alto livello e realmente tale, che in qualche modo codifica, a fini didattici, le intuizioni e le soluzioni derivate dall’alto livello, sia, in modo surrettizio, condizionante per l’alto livello stesso, limitandone lo sviluppo.
A confrontarsi e collidere sono proprio due modelli pedagogici e due modalità d’apprendimento e crescita dell’atleta, che non necessariamente si escludono (un buon esecutore può bene essere un buon interprete), ma che comunque vanno coniugati, operativamente, in modo consapevole e critico.
Possiamo chiamarli:
-
convergente vs. divergente,
-
globale vs. analitico,
-
cognitivo verbale vs. sensoriale,
-
cognitivo sistematico vs. intuitivo ecc.
Quello che c’interessa, come tecnici, è avere chiaro che l’agonismo e l’alto livello necessitano di un pensiero “aperto”, divergente, intuitivo, emotivamente evoluto e integrato, che va formato in età giovanile e tenendo conto delle caratteristiche individuali del giovane atleta.
Faccio notare, per inciso, che chi fa agonismo o viene dall’agonismo, tendenzialmente, sviluppa proprio una struttura caratteriale “rigida” (in senso non giudicante ma psicologico), con i suoi pro e i suoi contro, ma che è agli antipodi da quella flessibilità mentale che caratterizza il pensiero divergente.
Ne deriva che la spiegazione in sé non è utile, o ha un’utilità parziale con alcuni target (ad esempio con l’amatore adulto), e una costante attitudine interpretativa, la capacità di porsi domande, è più funzionale del “fornire risposte” e di una comprensione fine a se stessa; tanto per l’evoluzione tecnica dell’atleta, che per la crescita delle abilità mentali.
Come scritto altrove, infatti, la divisione tra processi percettivi, motori e cognitivi è in grande misura artificiale. Non solo la percezione è ancorata alle dinamiche dell’azione diventando più composita di quanto si ritenesse in passato, ma il cervello che agisce è anche e soprattutto un cervello che comprende.
Quindi – anche contro un certo interesse della mia professione, che invece utilizza in modo importante la leva cognitiva o cognitivo-emotiva – dall’azione alla comprensione, dalla sensazione alla cognizione, dai processi motori a quelli interpretativi; lasciandosi in qualche modo guidare dal contesto, dalle variabili situazionali o indotte, senza temere i tempi, pure ampi, di latenza e assenza di risposte.
Non si fa risultato seguendo una retorica della volizione, dell’impegno, ma il risultato “emerge”, là dove si danno tempi, modi, requisiti, condizioni perché esso emerga.
L’allenatore, il mental coach, presidiano queste aree di risultato, ma – come evidente – non lo determinano, pur avendo parte in esso.
E la didattica è un didattica certamente fondata sulla relazione, in chiave educativa, su apporti linguistici, dove il linguaggio della pedagogia è un linguaggio “plurale”, nel senso che ricorre a termini e concetti derivati da aree affini o diverse, facendo ampio uso di metafore, similitudini, ampliamenti di senso (Cfr. https://www.scimagazine.it/prospettive-levoluzione-della-tecnica-nello-sci-alpino-questioni-conoscitive-pedagogiche-comunitarie/), ma soprattutto esperienziale.
Grazie a una didattica di questa natura, secondo la quale gli aspetti della cognizione (idee, pensieri, concetti, categorie) emergerebbero da aspetti del corpo (percezioni e intuizioni sottostanti alle capacità di movimento, attività e interazioni con l’ambiente), diventa chiaro come un punto di vista somatico possa portare ad una “cognizione incorporata” di qualsiasi aspetto attenga la pratica sportiva in genere, e l’agonismo in particolare.
Quello che facciamo riferendoci a difficoltà tecniche, o mentali, o ad altre, è una scomposizione che, nella migliore delle ipotesi, ha una valenza colloquiale e didattica. A meno che non s’intenda per “tecnica” – e sarebbe opportuno farlo – quell’esperienza di cui sopra (Embodiment), dalla quale a posteriori traiamo idee, supposizioni, convinzioni, similitudini, parole. (Cfr. Ibid.)