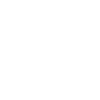Lo sciatore “preoccupato” e lo sciatore “capace” – Seconda parte
Nell’articolo precedente, al quale rimando – Lo sciatore “preoccupato” e lo sciatore “capace” – Prima parte, abbiamo messo a tema il discorso sul rapporto tra Autostima, Autoefficacia percepita e “stile esplicativo”.
Abbiamo quindi sottolineato l’importanza del linguaggio, del modo in cui raccontiamo (a noi stessi e agli altri) le cose e del modo in cui leggiamo e collochiamo le nostre esperienze, in specie se “negative”, cioè a dire non rispondenti alle nostre aspettative.
Abbiamo concluso l’articolo riferendoci alla teoria dell’Impotenza appresa (Seligman), con la quale ci si riferisce al comportamento manifesto di un soggetto che ha fatto esperienza, subendoli, di stimoli avversi al di fuori del suo controllo.
È frequente nel mio lavoro con giovani atleti che alcuni di loro, assolutamente capaci in situazione di allenamento e se vogliamo talentuosi, in gara perdano ogni riferimento tecnico positivo e non riescano sistematicamente ad esprimersi.
Questo divario, come normale che sia, è per loro assolutamente destabilizzante e sono davvero pochi quelli che traggono da questo tipo d’esperienza stimoli per fare meglio e affinare le strategie apprese.
Gli atleti o le persone che percepiscono gli eventi come al di fuori del proprio controllo, mostrano dei tratti che possono anche minacciare il loro benessere psico-fisico. Sono infatti spesso sotto stress, mostrano elementi di passività o di aggressività e possono anche avere difficoltà (se sotto pressione) a svolgere compiti cognitivi di modesta entità.
Imparare che un evento è incontrollabile, quindi, ostacola la possibilità di apprendere che le risposte date possono invece modificare la concatenazione dei fatti, creando così un vero e proprio deficit cognitivo.
Si parla pertanto, in questi casi, di una “distorsione cognitiva” riguardante la percezione della propria incapacità di modificare l’ambiente.
I deficit connessi a questa percezione di sé rispetto al contesto, sono almeno di tre ordini:
1. Motivazionale: ritardo nell’emissione di risposte appropriate in situazioni in cui gli eventi sono o potrebbero essere controllabili,
2. Cognitivo: difficoltà nel percepire la relazione tra risposte emesse e risultati,
3. Affettivo/emotivo: tono dell’umore “basso”, disforia.
Inizialmente si riteneva che il senso d’impotenza fosse originato dall’accettazione da parte del soggetto dell’impotenza stessa, il che lo portava a interrompere i tentativi di evitare o di sottrarsi allo stimolo avverso.
Negli ultimi decenni, invece, la neuroscienza ha fornito nuove informazioni sull’impotenza appresa, ribaltando del tutto la teoria originale: secondo le nuove teorie, il cervello è predisposto a ritenere di non avere alcun controllo sulle varie situazioni, ed è invece il concetto di “potenza” ad essere appreso.
Domandiamoci ora: ma come ragiona uno sciatore “capace”? Come ragiona uno sciatore che si percepisce in grado di gestire il compito (“potente”) e che trae stimoli e informazioni positive da un’esperienza che altri percepiscono come fallimentare?
Siamo qui al versante metacognitivo dell’educazione (il versante dello “imparare ad imparare”), che ha un posto di assoluta rilevanza sul piano degli apprendimenti e del metodo.
Oggi con il termine funzioni metacognitive si indica il livello evoluto delle capacità autoriflessive e di controllo della coscienza; capacità derivate dalla storia di apprendimento e di conoscenza che la persona sviluppa rispetto ai propri processi mentali e alle loro caratteristiche, nonché dall’auto-osservazione delle dinamiche esecutive che presiedono alla regolazione dei processi cognitivi.
La metacognizione di un individuo comprenderà quindi la conoscenza delle sue abilità, la natura dei processi, le strategie per affrontarli, l’abilità di monitorarli prima, durante e dopo l’esecuzione di un compito.
Anche se un approccio metacognitivo al compito non necessariamente è garanzia di successo, gli atleti che mostrano un buon funzionamento sul piano agonistico, o altri sul piano professionale:
– hanno obiettivi di padronanza (distinti da quelli di prestazione, in quanto utilizzati per sviluppare le proprie abilità) ad implementare il senso di autoefficacia percepita
– manifestano stati emotivi positivi verso il compito
– considerano gli insuccessi come stimoli per un maggiore impegno
– esprimono prognosi positive sui propri risultati
– adottano strategie efficaci e le mantengono o migliorano dopo un insuccesso
– fanno uso in modo costruttivo di autoistruzioni e automonitoraggio, cioè cercano di tenere adeguatamente sotto controllo le operazioni cognitive che svolgono
– utilizzano uno “stile esplicativo” degli eventi negativi non stabile e globale (pessimismo), ma caratterizzato da momentanee e specifiche spiegazioni degli eventi avversi (ottimismo).
Enrico Clementi – Educatore, Formatore, Consulente e Trainer educativo
Autore de: L’allenamento mentale nello sci alpino. Prospettive e strumenti dal mondo dell’educazione (BMS, 2020) http://www.bmsitaly.com/prodotto/allenamento-mentale-nello-sci-alpino/
Per info, contatti, attività formative e di orientamento: enricoclementi017@gmail.com