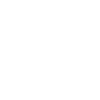Il talento nello sci alpino, tra realtà e mito
Nel dibattito riguardante il talento nello sci alpino, sono spesso contestate quelle scelte di atleti, o giovani atleti, che in qualche modo divergono dalle logiche federali; che prevede tempi, modi, passaggi obbligati, forse adeguati un tempo, ma che oggi, per ragioni storiche e sociali, risultano essere poco efficaci.
Se è vero che la “prestazione di picco” nello sci alpino si raggiunge nell’età adulta, per ragioni di forza, massa muscolare, abilità tecniche specifiche ed esperienza in determinati circuiti, e quindi sembrerebbe adeguato uno sviluppo dell’atleta “a lungo termine”, non possiamo ignorare altri fattori.
In primis le caratteristiche cognitive delle nuove generazioni, rispetto alle precedenti, che, seppure sembrano mostrare alcune fragilità da un punto di vista caratteriale (abbiamo analizzato la cosa in altro contesto), sono obiettivamente smart, ossia intelligenti, accorti, da altri punti vista.
Se centrati sul compito – semmai è questo il discrimine! – apprendono più rapidamente, mostrano maggiori livelli di autonomia, di libera iniziativa, rispetto alle precedenti generazioni; inoltre comunicano meglio, si esprimono meglio, identificano in modo più chiaro i loro bisogni.
Anche le relazioni di potere sono diverse, nei confronti dei genitori, degli insegnanti, degli allenatori e di altre figure adulte di riferimento: se fino alla generazione scorsa i criteri di autorità sembravano dettare le regole della relazione, oggi non è più così e i giovani, al di là dei facili giudizi, sono in grado di mettere in discussione il principio di autorità e assumere posizioni proprie.
Per questo la scelta di alcuni talenti di rivolgersi ad altre strutture federali e ad altre realtà organizzative dalla FISI (Lara Colturi non è l’unico esempio), ci sembra, dati gli attuali assetti federali, assolutamente giustificata in virtù del tema che andremo a sviluppare, ossia la tutela e lo sviluppo del talento.
Nessuno me ne voglia ma è evidente che la nostra Federazione stenta ad innovare, a valorizzare proposte, professionalità, contributi teorici, che pure ci sono; e privilegia un assetto conservatore, verticistico: non è un caso se oggi si sente sempre più parlare dell’esigenza di creare organizzazioni “smart”, in grado cioè di operare efficacemente in contesti complessi, in evoluzione continua e in condizioni di forte ambiguità.
Giovani smart, organizzazioni societarie, staff di lavoro, federazioni sportive smart, che sostituiscano alla verticalità l’orizzontalità, al monopolio i processi di delega, al decisionismo la valorizzazione delle competenze e la cooptazione.
La realtà è che in risposta alla complessità, alle pressanti richieste di cambiamento, alle scelte divergenti di talenti e tecnici, la maggior parte delle organizzazioni sportive – e la FISI non fa eccezione – si sono chiuse, arroccate in difesa e hanno perso funzionalità, agilità e sono in confusione, perché hanno sviluppato “complicatezza”.
Anatomia di un talento
Anziché domandarci cosa sia il talento, partiamo dall’opposto e facciamo il caso inverso, di un talento che non è riuscito ad esprimere il suo potenziale.
Che cosa ci racconterebbe un talento “morto” se lo sottoponessimo a un attento esame autoptico?
La causa della mancata fioritura, ci svelerebbe i suoi vissuti, l’entità delle esperienze, la qualità del supporto ricevuto?
Ci direbbe cosa gli è mancato per mantenersi in buona salute e cosa gli abbia inferto il colpo finale?
Ancora: scopriremmo mai che cosa sia o non sia un vero talento?
Ma soprattutto: dobbiamo per forza farlo morire questo talento prima di vedere con i nostri stessi occhi (questo significa in fondo autopsia) come si formi, come interagisca con il contesto e come il contesto agisca la sua influenza?
E nel contesto abbiamo relazioni familiari, supporto tecnico, economico, dotazioni materiali, dinamiche comunicative, incursioni dei media, opinionisti ecc.
La biologia del talento
Si dice, a ragione, che il talento agonistico poggi su una dotazione genetica che alcuni hanno, e altri no.
Non mi addentro in questa spinosa questione, ma faccio un breve riferimento a quella sostanza isolante, costituita prevalentemente da lipidi e proteine, detta mielina; sostanza che ha la funzione principale di consentire la corretta conduzione degli impulsi nervosi, amplificandone la velocità di trasmissione attraverso la cosiddetta “conduzione saltatoria”.
La mielina, o membrana mielinica, è una sorta di guina, di involucro sigilla talento.
Ogni volta che ripetiamo un gesto per correggerlo, o un’azione complessa per affinarne l’efficacia, fino al punto di perfezione (o quello che decidiamo essere tale), la membrana mielinica che avvolge il neurone che informa quella specifica azione si ispessisce rafforzando l’abilità.
C’è inoltre una componente plastica, di assoluto rilievo per il nostro sport, che va anch’essa allenata, e che ci permette di implementare l’abilità stessa e, a seconda dei casi, di modificarla.
Quindi: ogni volta che ripetiamo un gesto, ogni volta che correggiamo, ogni volta che ci concediamo la possibilità di sbagliare, il nostro organismo, la nostra mente, apprende.
Se dovessi sintetizzare in uno slogan (ho parlato altrove di “pedagogia dell’errore”): prova ancora! Fallisci ancora! Fallisci meglio!
Il talento come “ forzatura”
C’è un gioco di Daniel Coyle in The Talent Code (2020), che a volte propongo ai giovani atleti per dimostrare il ruolo che l’impegno e lo sforzo hanno nell’apprendimento.
Nel gioco, che non riporto integralmente per ragioni di opportunità e di spazio, si hanno due batterie di parole abbinate tra loro, una con parole complete, l’altra con parole da completare mentalmente. Tipo: colonna A: sabbia/mare; olio/aceto; giorno/notte ecc. Colonna B: dol_e/salato; mese/a_no; al_o/basso ecc.
Poi chiedo di scrivere su un foglio le coppie memorizzate, derivate, indistintamente, dalla colonna A o B. Nella maggior parte dei casi i partecipanti riportano molte più parole della colonna B, che non della colonna A.
La domanda: com’è possibile che della colonna A, dov’è tutto più semplice, immediato, lineare, i partecipanti abbia memorizzato meno coppie di parole?
La risposta è: perché la colonna B ha richiesto più sforzo e fatica, e ampliato i tempi di latenza. Quindi: difficoltà, sforzo, prove/errori, lentezza, introspezione e tempi di latenza.
Se nella prima colonna i partecipanti non hanno incontrato alcun inciampo e la lettura si svolta in modo fluido, nella seconda hanno dovuto per forza di cose fermarsi almeno un attimo e capire di cosa si trattasse, per poi colmare i vuoti, trovare la lettera mancante e ricostruire la parola per poter infine memorizzare la coppia.
Per questo nel titolo del paragrafo dico che il talento è una forzatura, cioè un sforzo: le prestazioni senza sforzo, forse, sono più desiderabili, ma sono pessime alleate del talento.
Il talento infatti opera ai confini della cosiddetta predisposizione naturale, e anche ai confini delle capacità e abilità già acquisite.
Se dovessimo trovare l’origine del talento, dovremmo quindi cercarlo nel divario tra ciò che sappiamo e ciò che proviamo a fare: è quello infatti il punto di decollo, oppure di rovinosa caduta, del nostro talento.
Sono le esperienze di soglia tra ciò che sappiamo e ciò che proviamo a fare che ci costringono a rallentare, a fare errori e a correggerci.
Sbagliare e correggere. Sbagliare ancora, correggere di nuovo, memorizzare l’abilità acquisita. Migliorare di correzione in correzione, di forzatura in forzatura del confine.
Ossia, il talento non come nozione astratta, ma come pratica, o prassi operativa, che pure ha dei risvolti etici, valoriali.
In questo senso anche la motivazione è un’astrazione, se non ancorata a quegli stessi risvolti etici e valoriali che sostengono lo sforzo, la fatica e quindi, da ultimo, permettono al talento di esprimersi e di essere tale.
Il mistero del talento
Si dice che il perché, è più importante del come e che chi ha un buon perché, trova sempre il come.
Abbiamo capito che il talento è qualche cosa in parte di oggettivo (dotazione biologica), ma in larga parte è pratica deliberata, sforzo, dedizione, cura, passione, sacrificio, gestione dell’imprevisto ecc.
Se capiamo questo, comunque, non capiamo ancora bene perché alcuni amano qualche cosa magari con la stessa intensità, ma non attivano o non riescono ad attivare quell’insieme di strutture che permettono al talento di rafforzarsi e di esprimersi.
Cosa ci spinge verso quel particolare talento, e non verso un altro? Cos’è che ci dà una certa predisposizione, e non un’altra?
La risposta e minimale, quasi disarmante, almeno fino a quello che sappiamo oggi, ed è: il caso.
Come spiega John Bargh in un libro titolato A tua insaputa (2018), gran parte delle nostre azioni sono guidate dal nostro cervello arcaico, e sono quindi in buona parte non consapevoli.
Certo nello sci alpino abbiamo contesti, modelli familiari, stili genitoriali, che possono contribuire o meno ad innescare il nostro piacere di stare in ambiente innevato e sugli sci, e che possono contribuire o meno a svolgere la pratica agonistica, con tutto quello che essa comporta in termini di sacrificio. Ma, detto questo, gran parte delle scelte che ne susseguono sono reattive: reagiscono cioè agli stimoli che riceviamo da ogni parte della nostra vita, e che in qualche modo ci colpiscono, fanno breccia in noi.
Conosco figli di allenatori e tecnici di indubbio spessore che non hanno nulla a che fare con lo sci, mentre altri decidono di fare attività agonistica professionalmente. E non possiamo dire che in questi casi i primi, in modo diretto o indiretto, non siano stati bombardati da informazioni e modelli che avrebbero lasciato supporre quanto meno un avvicinamento al mondo dello sci agonistico.
Il più delle volte ad incidere è qualcosa che va a stimolare il nostro istinto primordiale all’appartenenza, che è anche un istinto all’identità: vogliamo fare parte di qualcosa, avere un’identità in cui riconoscerci e essere riconosciuti.
Detta in altri termini, vogliamo un’identità, un futuro, magari da agonista, o da tecnico, o da trainer, che non vediamo distintamente, ma che pure esercita una forza attrattiva. Perché lo abbiamo intravisto, sfiorato e annusato e per ragioni poco razionali e razionalizzabili, ci ha sedotti.
A questo si aggiunge un altro trigger motivazionale incorporato dagli albori dell’umanità: il cervello è costantemente a caccia di sfide, lotte, missioni a volte possibili, altre impossibili.
Vuole sapere, millesimo di secondo per millesimo di secondo, cosa deve fare, dove deve indirizzare l’energia; e incalza: Ora che faccio? E adesso? E adesso? E adesso? Come gestisco questo imprevisto? Come mi rimetto in piedi? Come rispondo a questa provocazione? ecc. Senza soluzione di continuità.
Conclusione
Abbiamo ora qualche risposta alle nostre domande di partenza e ci auguriamo non ci siano da uccidere altri talenti, prima di capire come permettere ad essi di esprimersi, ma in special modo come tutelarli.
Sappiamo quindi cos’è il talento, da dove viene e dove va, come riconoscerlo, come orientarlo senza soffocarlo.
Ad autopsia conclusa possiamo dire che:
- – il talento è un’abilità portata al massimo del suo potenziale;
- – nasce dalla nostra capacità di immaginare un futuro desiderato – ma anche dalla capacità di perseverare e di agire un pensiero positivo
- – lo riconosci quando ti sposti un passo oltre il confine dei tuoi limiti, ma allo stesso tempo fai attenzione a non cadere nel baratro dell’illimitato;
- – sai che è un tuo talento se sei disposta, o disposto, a fare tutto quello che puoi per aggiustare il tiro, correggerti e migliorare, pure se le condizioni di partenza non sono facili, pure se il contesto non è il migliore possibile per proseguire, pure se il percorso è irto di ostacoli e – facciamo i nostri auguri a Lara per il suo infortunio – incidenti.
Prova. Prova ancora. Fallisci. Fallisci ancora. Rialzati. Fallisci meglio.
Enrico Clementi enricoclementi017@gmail.com