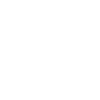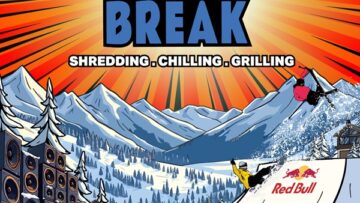Il mentale nello sci alpino secondo Enrico Clementi: questioni aperte e prospettive
Abbiamo realizzato un’intervista a Enrico Clementi, che cura per noi, dal luglio scorso, una rubrica sul mentale nello sci alpino, i cui vari contributi sono reperibili al link
https://www.scimagazine.it/?s=enrico+clementi
Abbiamo inteso fare con Enrico una conversazione a 360° sulle caratteristiche di personalità dell’atleta in rapporto alla comunicazione, sull’allenamento mentale, sul ruolo e sulle funzioni dell’allenatore, sullo stato dell’arte (relativamente al mentale) nelle categorie giovanili ecc.
Quella che emerge dall’intervista è una logica di ragionamento più educativa, che psicologica; ossia più attenta al trasferimento di conoscenze e competenze operative all’atleta e, in chiave formativa, all’allenatore, che a “misurare” la prestazione, avvalendosi di metodi, teorie o modelli.
Ricordiamo che Enrico Clementi è autore di un libro titolato “L’allenamento mentale nello sci alpino”, che, in modo emblematico è sottotitolato “Prospettive e strumenti dal mondo dell’educazione”; ci sembra quasi che il sottotitolo, leggendo la sua intervista e avendo letto i suoi articoli, sia il vero titolo del manuale!
Ricordiamo che il volume è pubblicato da BMS (2020) è reperibile al link
http://www.bmsitaly.com/prodotto/allenamento-mentale-nello-sci-alpino/
In quali ambiti, in quali aree è utile avvalersi di un trainer educativo (comunemente detto mental coach) o di uno psicologo dello sport quando si lavora, da allenatori, con singoli atleti o squadre di sci alpino?
Da un punto di vista prestativo è utile quando ci sono risorse da esplorare, o margini di crescita dell’atleta. Ma va sottolineato che l’approccio prestativo ha chiari limiti sul piano educativo, in specie nelle categorie giovanili.
Se ha un suo perché nell’alto livello – dove comunque lascia scoperte alcune aree di sviluppo dell’atleta sul piano evolutivo, della percezione di sé – nelle categorie giovanili rafforza la percezione, assolutamente fuorviante ed errata, che l’esperienza sportiva sia riducibile al risultato.
In questo senso e per eccesso già il cronometro è un elemento di forte impatto e disturbo per i giovani atleti, ma anche per le famiglie, per gli allenatori, in termini di vissuti e positività della gara.
Non so quale sia la soluzione, ma certamente il riferimento cronometrico dovrebbe solamente essere tale, per il singolo atleta, e non percepito come uno strumento di valutazione, di giudizio sul lavoro fatto e su quello da fare, sul processo.
Per cui una figura come la mia può sì fornire strumenti per aiutare l’atleta ad esprimersi al meglio delle sue possibilità, ma direi che può aiutare l’allenatore, gli staff, gli atleti, ma anche la dirigenza, se non a risolvere criticità di sistema, quanto meno a rilevarle e ad elaborarle in modo critico costruttivo.
Che differenze c’è tra una figura professionale con formazione educativa o psicopedagogica e un motivatore? Sembra che oggi siano molto gettonati.
La differenza è sostanziale, essendo queste figure, rispettivamente, provenienti da un percorso di laurea socio-educativo o pedagogico-educativa, piuttosto che da una laurea in psicologia.
Inoltre sappiamo oggi che non si motiva qualcuno dall’esterno (motivazione estrinseca), se non con effetti di breve durata, ma ci si motiva a partire dal proprio sistema valoriale e dai propri obiettivi (motivazione intrinseca); poggiando la motivazione su sentimenti relativamente stabili e duraturi e non su emozioni – che per loro stessa definizione sono transitorie e di breve durata.
Inoltre, come dicevo in apertura, la motivazione è legata in larga misura ai vissuti dell’atleta; che, nelle categorie giovanili, si alimentano dei vissuti e delle risposte, degli atteggiamenti, delle proiezioni dei genitori: è assolutamente normale e adeguato che motivazione intrinseca ed estrinseca, nei più piccoli, si condizionino a vicenda.
Un educatore o un trainer educativo, appunto, aiutano l’allenatore, la dirigenza, i genitori, i ragazzi, a cogliere queste dinamiche, a lavorarle (esse stesse diventano strumento, palestra per la conoscenza di sé e la crescita) e da ultimo a non subirle.
Come conquistare la fiducia di un atleta? Ci sono dei modi, delle tecniche?
Premetto che non sono una persona – e di conseguenza un professionista – che “rincorre” il consenso e gestisco le relazioni lasciando sempre spazio a ché l’altro possa avvicinarsi a me, allontanarsi, osservare e valutare se e come cercare un confronto.
Non ho fretta di creare relazione, per il semplice fatto che l’essere in fiducia, l’entrare in fiducia, il creare alleanze, seppure educative, è esso stesso un obiettivo: non è scontato che il contesto crei appartenenza.
Fatta questa premessa, parlare di fiducia è fondamentale: un atleta o una squadra che sono “in fiducia” sono capaci, performanti; viceversa, se non lo sono “in fiducia” non sono neanche in grado di esprimere i propri punti di forza e anzi prevarranno quelli di debolezza.
Per cui la fiducia – nell’accezione anzidetta dello “essere in fiducia” – è a tutti gli effetti un obiettivo per il coach e come tale va trattato e posto.
Credibilità umana, empatia, metodo ecc. sono di fatto strumenti operativi concreti, attraverso i quali il coach facilita nell’atleta un atteggiamento positivo al compito.
Come facciamo a capire se i nostri atleti sono “in situazione”, rispetto all’allenamento, o alla squadra, o al contesto, oppure no?
Metodi diversi, utilizzano strumenti diversi per valutare questo aspetto; per cui si parla di attivazione, sincronia, presenza nel “qui ed ora” della situazione e simili. Comunque ci sono atteggiamenti, comportamenti dell’atleta che per il mental coach sono indicativi in questo senso
Ad esempio, al cancelletto, ho molte informazioni indirette sullo stato emotivo dell’atleta, facendo attenzione alla gestualità, alla postura, ai movimenti del capo, all’orientamento dello sguardo e ai così detti movimenti saccadici.
C’è inoltre l’evidenza del risultato, non solo e non tanto cronometrico, che rende leggibile l’essere l’atleta (o meno) in sincronia sui tre livelli fondamentali: mente, corpo, ambiente.
Questa sorta di allineamento tra mente, corpo e relazione con l’ambiente, permette all’atleta, per fare un esempio, sia di anticipare risposte motorie, tempismi, adattamenti, che di differenziare le risposte stesse.
Quelle evidenziate, cioè anticipazione motoria e trasformazione-adattamento, sono le abilità chiave dello sci alpino e degli sport di situazione, che appunto richiedono abilità e attitudini assolutamente flessibili, “aperte” (Open Skills).
Prima di una gara importante o di qualificazione, come deve comportarsi un allenatore? È giusto evidenziare l’importanza di questo appuntamento, oppure meglio non mettere pressione all’atleta, o al gruppo, o alla squadra?
Oggi l’evidenza scientifica ci dice che l’essere sotto pressione, non è mai favorevole alla prestazione.
La pressione quindi va evitata, perché comunque presente e generata da tutto quello che ruota attorno alla gara: organizzazione, aspettative personali, familiari, avversari, ecc.
Il lavoro del coach e dell’allenatore, in questo caso, è invece quello di “decomprimere” l’atleta da questa serie di aspettative e pressioni, spostando l’ago della bilancia dalla situazione problema, all’opportunità: la gara non è un problema da risolvere, qualche cosa dal quale uscire, ma appunto un’opportunità d’esperienza, di crescita, ma anche di successo per l’atleta performante.
Vedo giovani che recuperano il sorriso dopo la gara, cioè a dire quando ormai sono fuori da quell’evento che per loro non rappresenta un’opportunità, ma un male necessario, qualche cosa che subiscono.
Questa esperienza è molto frequente al cancelletto e per questo, in apertura, ho insistito sui limiti dell’approccio prestazionale.
In questo senso dovrebbe essere evidente all’allenatore, nei giorni o nei momenti che precedono la gara, non l’ansia o la preoccupazione del risultato da parte dell’atleta che è un indicatore negativo, ma il gusto, il piacere di mettersi alla prova e di vedere che cosa ricava dal suo impegno e dalla mole di lavoro svolto.
Noi siamo efficaci non quando facciamo podio, ma quando esprimiamo quello che abbiamo allenato!
Il fine dell’allenamento è appunto quello di esprimersi al meglio delle proprie possibilità. Non per ricevere il plauso di altri, o un riferimento cronometrico che ci fa sentire capaci, piuttosto che incompetenti o inetti, ma per il nostro piacere.
Lo sci alpino, al pari di altri sport e di altre forme espressive umane, tipo l’arte, il rito e simili, è un’attività “autotelica”, cioè a dire gratificante in se stessa e non finalistica!
Qual è il modo migliore per elaborare una sconfitta? In specie quando si è fatto tutto quanto si poteva fare per ottenere un buon risultato. Va minimizzata, sottolineata o cosa?
La sconfitta o l’errore – come sappiamo dall’educazione – non sono più tali, se diventano un’opportunità di apprendimento, di migliorare le nostre competenze e strategie.
Io lavoro al fine di sviluppare una vera e propria “pedagogia dell’errore” partendo dal fatto che esso è: Normale, perché fa parte dell’esperienza e dell’attività dell’essere umano; Positivo, perché permette di far giungere il soggetto a conoscenze più prossime al successo delle azioni; Utile, perché – come anticipato – lo mette in condizione di imparare dagli errori.
Un suggerimento importante, per l’atleta e lo staff, è comunque quello di non fare considerazioni o valutazioni “a caldo”, a ridosso dell’eventi, perché le emozioni presenti falsificano la percezione di quanto realmente avvenuto.
Sarebbe anzi utile lasciare “a se stesso” l’atleta, o l’allenatore, con i sentimenti di tristezza, rabbia, che certamente daranno informazioni di varia natura: se sono a contatto con la mia sofferenza e frustrazione, deriverò da esse elementi evolutivi.
Il debriefing va fatto il giorno dopo, o a distanza di qualche giorno, dove le emozioni si sono sopite, sono state integrate e c’è una maggiore lucidità per fare un’analisi di quello che è successo e perché è successo. Quindi, no giustificazioni o scuse, ma elementi di comprensione e di crescita per ulteriori apprendimenti.
Inoltre non ha senso “rincarare la dose” da parte dell’allenatore, là dove un atleta ha effettivamente fatto una prova deludente, rispetto ai suoi standard, o errori macroscopici, perché sarà già egli stesso ad avere consapevolezza di questo e a dirsi quello che sa.
Certamente il coach, o l’allenatore, potranno invece aiutarlo nell’analisi di contesto e nell’elaborare strategie di gara migliori per gli appuntamenti a venire.
Soprattutto con le categorie giovanili c’è poi da coniugare l’attività agonistica, con la vita e gli impegni di tutti i giorni, ma anche a volte con le problematiche familiari o adolescenziali. È opportuno che l’allenatore entri in questa sfera e quanto è giusto che vi entri?
La risposta è complessa, perché è complesso il ruolo del coach in questo momento storico.
Ci sono oggi aspetti pedagogici, sociologici, psicologici e non solo tecnico-sportivi dei quali, come allenatori o coach, dobbiamo tenere conto.
Per cui è compito dell’allenatore formarsi anche su aspetti di questo genere, sia che lavori con i giovani che con l’alto livello; perché la richiesta della società (giusto o sbagliato che sia) è che egli si occupi, anche e non secondariamente, di questi aspetti.
Comunque un confine chiaro va posto con i giovani, in specie nelle aree di conflitto, ed è importante che alcune scelte, ad esempio con i genitori, restino di responsabilità del giovane e non siano invece mediate dall’allenatore.
Altrimenti il rischio è che il giovane vada in confusione e presenti l’allenatore come suo alleato (triangoli, come si dice), nel caso egli abbia espresso idee difformi da quelle della famiglia.
Diventa un nodo dal quale poi è complicato uscire, oltre ad essere una “invasione di campo” assolutamente impropria da parte del tecnico.
Va comunque detto che trovo in genere il contesto assolutamente impreparato a cogliere questa sfida e a gestire relazioni complesse in modo non provvisorio, discrezionale, ma finalistico, educativo, così come dovrebbe essere.
Non dimentichiamoci che l’ambiente sportivo, lo sci club, sono a tutti gli effetti contesti educativi, ancorché non-formali; quindi, accanto alla famiglia, alla scuola e ad altre forme aggregative, lo sci club è una agenzia educativa che, seppure in modo circoscritto, può/deve farsi carico di istanze diverse dal risultato agonistico.
E nel caso di atleti adulti che portino in pista problematiche o tensioni derivate dalla loro sfera privata?
Direi che di massima vale il discorso appena fatto, anche se dipende dalle caratteristiche della persona e dai suoi strumenti di comprensione, elaborazione, integrazione dei vissuti.
Comunque una persona è “adulta” per due caratteristiche fondamentali, che possiamo richiamare e delle quali avvalerci nel nostro lavoro: sa stare nel qui ed ora; sa farsi carico dei suoi problemi e sa attivarsi per risolverli.
Quindi possiamo certamente richiamare l’adulto alle sue responsabilità d’atleta e alla sua professionalità (essere nel qui ed ora, sincronia) e suggerirgli di trovare soluzioni ai suoi problemi, magari chiedendo un aiuto esterno o un aiuto specialistico, qualora ne avesse bisogno.
Certamente non è escluso il confronto privato con l’atleta, ma anche qui attenti al rispetto dei confini (anche in virtù delle differenze di genere), che persone diverse interpretano e gestiscono in modi appunto diversi.
Resto sulle categorie giovanili (so che te lavori molto con gli sci club e credi in una formazione diffusa legata al mentale anche con i giovani): come comportarsi con quei ragazzi che in allenamento o in gara, oppure in trasferta, continuano ad avere un cordone ombelicale saldo con i genitori, piuttosto che con l’approvazione dell’uno o dell’altro allenatore? Magari, appunto, a scapito del qui ed ora e del lavoro di crescita personale, perché focalizzati all’esterno.
Sto scrivendo un articolo sul discorso genitori e famiglie e sto immaginando percorsi formativi ad hoc rivolti a queste importanti figure di mediazione dell’esperienza del giovane.
Lo sci club è un organismo complesso, dove convivono e a volte confliggono visioni e interessi molto diversi e distanti tra loro: gestionale-economico, d’immagine, tecnico, emotivo, affettivo, di realizzazione ecc.
Tra questi mondi, pure legittimi ognuno a suo modo, non vi è dialogo sistematico, ma vi sono compromessi assolutamente provvisori e fragili, non in grado di governare la pluralità di bisogni, vissuti, pressioni, richieste.
Comunque, limitatamente ai giovani (il discorso si amplierebbe oltremisura), vanno trasferiti strumenti di conoscenza al giovane atleta, di comprensione dei fenomeni, perché già a 13-14 anni è bene in grado di capire cosa sia opportuno e cosa no, in un determinato contesto.
Per questo credo nel lavoro di alfabetizzazione, ossia in una pratica che permette ai giovani atleti di ragionare sul dettaglio, di esplorare comportamenti, o atteggiamenti, che altrimenti rischia di subire in modo inconsapevole e passivo: è assolutamente normale che un genitore, o una allenatore, siano un punto di riferimento per un giovane atleta e la motivazione proveniente dall’esterno e quella interna, fino a una certa età, sono complementari.
Però vanno anche trasferiti strumenti e chiavi di lettura, che suggeriscano al giovane perché è opportuno allentare quel cordone con la famiglia, perché è opportuno non dipendere (almeno in parte) dall’approvazione o meno di un allenatore, perché e come stare nel qui ed ora della situazione e perché e come facilitare gli apprendimenti. È quindi un aspetto che va allenato, seppure in chiave educativa e non meramente prestativa.
Compito dell’ambiente sportivo e delle società evolute è quello di fare formazione ai giovani, ai genitori, agli staff tecnici, ai dirigenti, su questioni di questo tipo, proprio per evitare insuccessi, dispendio di energie e risorse, frizioni e incomprensioni tra attori con funzioni diverse ma complementari.
Ci sono errori macroscopici che ti senti di indicare agli allenatori, data la tua esperienza sul campo?
Be’ sì ce ne sono diversi… (sorride) Diciamo i due o tre che mi sentirei però di indicare sono: la gestione dell’errore, che è qualche cosa che non si giudica, ma si descrive.
Spesso gli allenatori non fanno questo e l’errore non è considerato come opportunità di apprendimento, ma qualche cosa di negativo e che intossica il giovane atleta e lo inibisce ulteriormente nella ricerca di soluzioni: è evidente che se io rimprovero un’atleta dopo un errore, questi, per paura di ulteriori rimbrotti, farà difficoltà a sperimentare, proprio per la paura di ulteriori sbagli.
Indicherei poi una comunicazione che bandisca il “non”, dato che gli allenatori hanno un importante potere comunicativo con i giovani atleti e il “non fare questo”, o il “non fare quest’altro” rischia di diventare quello che tecnicamente è un “non obiettivo”.
In specie in gara, in ricognizione, la comunicazione è in qualche modo risolutiva: non ha senso dire quello che è bene fare, perché conveniente dal punto di vista prestativo, o da altri punti di vista, e dire al contempo quello che non si deve fare.
In fine vedo che nelle prove tra i pali, l’allenatore tende a dare tantissime informazioni all’atleta, mentre l’allenatore efficace è quello che dice poche cose e nel modo giusto (componente empatica); cioè con frasi molto brevi e concrete, ossia in grado di creare immagini mentali che permettano all’atleta di immagazzinare informazioni prima e poi, al bisogno, di reperirle, renderle operative, modificarle.
Su questo aspetto, assolutamente centrale nel lavoro dell’allenatore, che riguarda sia la comunicazione che il metodo, magari torneremo in qualche articolo dedicato o in un ulteriori confronti.
Enrico Clementi – Educatore, Formatore, Consulente e Trainer educativo https://enricoclementi.it/
Per info, contatti, attività formative e di orientamento: enricoclementi017@gmail.com