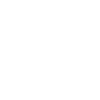Cosa può fare (e cosa no) il mental coach a bordo pista
In sede d’allenamento, nello sci alpino, è consuetudine che gli allenatori siano in pista e facciano un lavoro di osservazione e correzione degli atleti impegnati tra i pali.
L’esperienza dell’allenatore, la sua professionalità, lo mettono nelle condizioni di individuare le difficoltà dell’atleta e di suggerire soluzioni.
Queste difficoltà, per lo più, sono difficoltà di tipo tecnico, o tattico, oppure di adattamento, ma a volte anche d’atteggiamento e quindi mentali.
In molti casi, almeno in sciatori di livello, non è semplice separare l’aspetto mentale dal rendimento tra i pali e l’allenatore, in modo frequente, utilizza chiavi di lettura e termini che “psicologizzano” la prestazione.
L’ambiente dello sci alpino, come altri contesti, ha un suo gergo e ogni qual volta si fa riferimento, per dare qualche esempio, al “mollare” dell’atleta, al restare o meno nella sua zona di comfort, all’avere paura del ripido e simili, si sconfina appunto in un ambito che riguarda il mentale.
A questo punto, cosa può fare il mental coach “a bordo pista” e in che modo può essere di supporto all’atleta e all’allenatore?
Prima di rispondere a questa domanda, è bene che il mental coach o lo psicologo dello sport che lavorano in quest’ambiente e sul campo, conoscano bene le caratteristiche del contesto, al fine di evitare sovrapposizioni improprie con la figura dell’allenatore.
Certamente l’aspetto strettamente tecnico è di dominio dell’allenatore e a meno che non sia egli a richiederlo, vanno evitate considerazioni in questo senso, a prescindere dal grado di competenza personale raggiunto.
Anche nel caso di psicologi dello sport o mental coach che siano anche maestri di sci e allenatori – conosco alcune situazioni di questo tipo – il discorso non cambia: è opportuna una chiarezza di ruoli, sia a beneficio degli atleti che dello staff, al fine di evitare sovrapposizioni improprie tra funzioni comunque distinte.
Inoltre, il mental coach che lavora sul campo deve avere un buon grado di autonomia negli spostamenti in pista e deve essere attento alla comunicazione tra allenatori e tra allenatori ed atleti, non essendo affatto scontato che le informazioni giungano a lui; infatti, essendo lo sci alpino uno sport individuale e avendo in genere l’allenatore un passato d’atleta, è diffusa una certa autoreferenzialità con la quale bisogna saper convivere, limitandone gli effetti.
Chi conosce le dinamiche interne di uno sci club sa che ogni azione, a partire dagli spostamenti per raggiungere gli impianti, alla tracciatura, fino al rientro, sono in qualche modo “accelerati” e vanno assecondati cogliendone il senso.
C’è in tutto questo anche un aspetto emotivo che il mental coach “a bordo pista” deve saper gestire e che riguarda il fatto che, giustamente, il punto di riferimento per l’atleta è l’allenatore. Questo significa che l’atleta che finisce una prova si confronta in prima battuta con il tecnico e che questi, ancora una volta, non necessariamente permette al mental coach di entrare in dinamica, magari consultandolo su qualche cosa di sua competenza.
Queste caratteristiche di contesto possono risultare frustranti per una figura ancora ritenta “di supporto”, o “accessoria” in sede d’allenamento o di gara e magari voluta dalla dirigenza dell’organizzazione, senza un reale coinvolgimento dello staff tecnico.
Sta al mental coach leggere questo insieme di componenti, collocarle in modo adeguato, attrezzarsi come meglio può per essere autonomo sotto l’aspetto pratico, relazionale, emotivo e quindi svolgere la sua funzione a beneficio del giovane atleta.
Torniamo quindi alla domanda lasciata in sospeso: cosa può fare il mental coach “a bordo pista” e in che modo può essere di supporto all’atleta e all’allenatore?
Il suo è un lavoro che, visto dall’esterno e date le premesse di cui sopra, potrebbe sembrare in questa fase passivo: viceversa, egli svolge un ruolo di osservazione attiva che è fondamentale per la programmazione del suo lavoro e di quello dello staff. Egli deve:
– osservare l’insieme di dinamiche indicate, riguardanti il contesto, capendo se e in che modo influiscono sul clima interno dello sci club, del gruppo sportivo o della squadra e quindi sull’atleta;
– osservare le capacità dell’atleta di “monitorare se stesso” in termini di risposte agli input di contesto (abilità metacognitive), ovvero il suo grado di autonomia, fisica e mentale;
– stante il grado di autonomia, osservare, sia in allenamento che in gara, se esprime quei parametri che rendono efficace ed efficiente (cioè economica) la prestazione: determinazione/motivazione, controllo emotivo/centratura, dinamismo/energia/attivazione ecc.;
– osservare modi e tempi di comunicazione tra allenatori e atleti, nonché l’efficacia o meno di queste modalità e tempistiche, che variano da atleta ad atleta. Ovvero, osservare se l’allenatore tiene conto di queste differenze (è estroverso o introverso? Giudice o ricettivo? È logico? Emotivo? Sensoriale? Intuitivo?) e quindi modula le informazioni in modo rispondente alle caratteristiche dell’atleta;
– osservare l’atleta in termini di consapevolezza di sé, atteggiamenti, risorse tecniche, fisiche, mentali, abilità comunicative, emotive, relazionali e altre ancora (l. “abilità strategiche”);
– osservare la capacità dell’atleta di gestire l’errore, o l’insuccesso, sia sul piano strategico che emotivo, durante e nel post allenamento/gara (gestione della frustrazione e aggressività agonistica);
– osservare se l’atleta ha maturato abilità non riconducibili allo specifico della disciplina, ma comunque strumentali alla sua crescita personale e sportiva, ovvero: capacità empatiche, solidarietà, cooperatività, gestione della leadership e simili.
Quest’ultimo aspetto, che potrà sembrare secondario in uno sport individuale, nel mio modo d’intendere è comunque strategico sia alle dinamiche di gruppo (lo sci alpino è uno sport individuale, ma ci si allena, a seconda dei casi, in gruppo o in squadra), che alla crescita globale della persona-atleta.
Il lavoro di osservazione sopra indicato è propedeutico sia al lavoro di “alfabetizzazione” degli atleti (mental training) in contesto diverso da quello d’allenamento e di gara, ovvero il setting più o meno strutturato utilizzato dal mental coach per svolgere il suo lavoro ordinario, sia al lavoro individualizzato propriamente inteso (mental coaching).
È proprio l’osservazione nello specifico dell’attività agonistica che permette di orientare le proposte formative e quelle educative, secondo la “doppia centratura” di obiettivi che caratterizza sci club, squadre, gruppi sportivi: una sul singolo, l’altra sul gruppo.
Sarà mia cura proporre in un prossimo articolo quegli aggiustamenti di settore che potrebbero ottimizzare, anche a livello federale, l’apporto di figure diverse da quella dell’allenatore negli staff tecnici, fermo restando l’obiettivo comune; che, come detto in altra sede, è quello di facilitare l’allineare della prestazione reale dell’atleta, con quella potenziale.
Enrico Clementi – Educatore, Formatore, Consulente e Trainer educativo https://enricoclementi.it/
Autore de: L’allenamento mentale nello sci alpino. Prospettive e strumenti dal mondo dell’educazione (BMS, 2020) http://www.bmsitaly.com/prodotto/allenamento-mentale-nello-sci-alpino/
Per info, contatti, attività formative e di orientamento: enricoclementi017@gmail.com