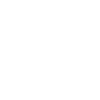Il talento nello sci alpino: per un approccio ponderato, multifattoriale e complesso
di Enrico Clementi
La serie di articoli pubblicati nella stagione 2023-2024 su questo magazine, hanno in qualche modo fornito elementi, numeri, statistiche (su dati FIS), per definire in modo più preciso cosa sia il talento nello sci alpino, e quali siano i fattori predittivi e i trend di sviluppo utili all’identificazione, crescita e tutela del talento. Cfr. https://www.scimagazine.it/la-variazione-della-performance-e-il-suo-valore-predittivo-nello-sci-alpino-tra-i-16-e-i-24-anni/
Secondo Joch (1992) ha talento, oppure è un talento, colui che, sulla base di disposizioni e delle possibilità che gli sono state offerte dall’ambiente nel quale vive, ottiene risultati prestativi non soltanto superiori alla media della sua età, ma suscettibili di sviluppo.
Tali risultati rappresentano il prodotto di un processo attivo di trasformazione pedagogicamente guidato e monitorato intenzionalmente attraverso l’allenamento, che è orientato verso quell’elevato livello di prestazione che dovrà essere raggiunto in determinate fasi nevralgiche dello sviluppo sportivo.
Per questa ragione, l’attitudine verso il talento deve essere il risultato di un processo attivo e dinamico, attraverso adeguate misure d’allenamento, delle abilità specifiche, della persona e della personalità dell’atleta.
Scoperta, identificazione, selezione e sviluppo del talento sono le fasi classiche nelle quali si suddivide la scelta degli individui meglio profilati per svolgere un compito, all’interno di un contesto che ha delle carattere specifiche.
L’Identificazione del Talento (TI) può essere definita come un processo per riconoscere gli atleti con un potenziale adeguato per diventare sportivi d’élite (Williams & Reilly, 2000).
Lo Sviluppo del Talento (TD) invece, mira a creare un ambiente di apprendimento il più appropriato possibile per permettere, ai selezionati, di realizzare, consolidare, tutelare il proprio potenziale (Reilly, Bangsbo, Franks, 2000a).
Quest’ultimo si riferisce, quindi, all’insieme di processi “a lungo termine” che mirano al miglioramento del livello prestativo – nello sci alpino un modello di sviluppo così concepito, è giustificato dal fatto che la prestazione di picco, come visto nei precedenti articoli, avviene in età matura, ossia tra i 20,5 ai 29,9 anni, a seconda del genere, della disciplina, del gruppo di appartenenza.
In qualsiasi processo di identificazione e sviluppo del talento (TID) sono presi in considerazione vari fattori, sui quali non mi dilungo perché ampiamente sviluppati altrove, che determinano l’iter motorio, e conseguentemente la prestazione dell’atleta al fine di raggiungere risultati di rilevo. Tali fattori sono:
-
fattori antropometrici;
-
fattori fisici e fisiologici;
-
fattori tecnici e cognitivo-motori;
-
fattori socio-affettivi e psicologici;
-
fattori riguardanti la performance in sé.
Con fattori sulla performance mi riferisco a quei dati inerenti i risultati nelle competizioni, che vengono troppo spesso presi in considerazione in quelle strategie d’identificazione del talento ormai ritenute obsolete: le vittorie a livello giovanile non necessariamente sono sinonimo di risultati in età adulta, in specie nelle categorie maschili (siamo al 7,8 % dei campioni giovanili che raggiungono il podio nel circuito maggiore, contro il 19,20 % delle atlete considerate: il 44,2 % si è presentata almeno una volta al cancelletto di partenza di una gara di Coppa).
Sono attualmente ritenuti modelli errati di individuazione e sviluppo del talento, a favore di quello “a lungo termine” sopra indicato e adottato dalla Federazione, la c.d. “specializzazione precoce”, e quei modelli di TI basati principalmente sulle caratteristiche fisiche, antropometriche e fisiologiche, che ignorano il fatto che la performance può essere la risultante di un’ampia gamma di fattori, molti dei quali possono variare col tempo.
Abbiamo già analizzato in questo senso il divario prestativo sovente determinato dall’età relativa dei giovani atleti (Relative Age Effect), e dal rapporto tra RAE ed età biologica (EB), e il successivo appianarsi di questo divario in età successive a quella puberale, ossia tra i 15 e i 17 anni.
In alternativa alla specializzazione precoce, le ultime ricerche vertono sulla diversificazione precoce e il cross-training, ovvero una sorta di formazione interdisciplinare tesa ad aumentare il bagaglio tecnico e motorio al fine di avere maggior probabilità di diventare atleti d’élite. Questo processo formativo avviene attraverso il trasferimento di abilità e capacità motorie da uno sport all’altro, che consente un incremento dell’expertise.
Ovviamente tale metodica perde i suoi effetti con livelli di competenza avanzati, ed ecco perché il cross-training viene utilizzato durante le prime fasi dello sviluppo del giovane atleta, necessitando successivamente un orientamento più chiaro verso la disciplina specifica.
Il talento, in qualsiasi area di performance e al di là dei criteri di selezione adottati, è un fatto multidimensionale e non lineare.
Sono molti infatti i processi interattivi e compensatori che prendono posto all’interno di una molteplicità di variabili, che includono: fattori fisici, fisiologici, motori, sociologici, psicologici, ambientali ecc.
Quindi, i tradizionali programmi TI che identificano l’atleta di talento su una gamma ristretta di fattori, anche specifici, potrebbero essere mancanti di capacità predittiva e quindi penalizzare in modo prematuro potenziali giovani talenti.
Riguardo alla specializzazione sportiva, essendo disciplina-dipendente, è opportuno, almeno per lo sci alpino, svolgere delle programmazioni “a lungo termine”. Il che non significa, evidentemente, avere una relazione blanda con il tempo e non tenere conto, in termini di progressione, delle differenze di genere e individuali.
Tuttavia parlare di programmazione “a lungo termine” non significa relegare i giovani e le famiglie in una zona neutra di indefinitezza e incertezza, come spesso accade, ma assumersi, come tecnici, delle responsabilità dirette in termini di valutazioni periodiche e capacità previsionali.
Attraverso l’esperienza pratica e i risultati del lavoro di ricerca, seguendo due tre anni di allenamento, è possibile distinguere dalla media, con una certa sicurezza, i giovani dotati di talento. E le caratteristiche sulle quali basarsi, solo per dare alcuni esempi, sono:
-
una reazione più efficace agli stimoli, motori o cognitivi che siano;
-
una reazione più favorevole a stimoli o richieste di elevata intensità;
-
applicazione più corretta e creativa delle soluzioni tecniche;
-
soluzione individuale dei problemi a maggiore autonomia decisionale e di scelta;
-
capacità costante di apprendimento, creatività, pensiero divergente e simili.
La prestazione agonistica ha un carattere complesso, che si manifesta nella coesistenza di molti fattori; dobbiamo quindi sottolineare che la ricerca del talento non è solo un problema di carattere motorio-costituzionale, né soltanto un problema d’ambiente e patrimonio genetico, ma è anche un problema di carattere sociale, etico, pedagogico.
Un discorso a sé meriterebbe la relazione tra talento e impegno, tra qualità innate o acquisite e intensità dell’allenamento, che svilupperemo in un prossimo articolo.
Basta dire che i sostenitori della pratica come chiave del successo fanno tutti riferimento a uno studio del 1993 dello psicologo statunitense Anders Ericsson: The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance, il quale si basa sull’assunto che chiunque può primeggiare in qualsiasi disciplina, se vi si applica intensamente e per un lungo periodo.
Certe semplificazioni, derivate da questo studio, come la regola delle 10mila ore, hanno il loro fascino, ma non reggono alla prova dei fatti. Le capacità di base contano molto, e non è vero che possiamo arrivare ovunque vogliamo solo con la determinazione e l’esercizio.
Il talento quindi in qualche modo esiste, anche se ancora non ne sappiamo dare una definizione precisa e puntuale. Ma di una cosa possiamo essere certi: senza la pratica, il talento non può emergere.
Ma questo è il nodo, e il senso del mio insistere sugli aspetti pedagogico-educativi: di quale pratica parliamo?
Non è l’allenamento standard che conosciamo, e che ritroviamo invariato, nelle forme e nei modi, dalle categorie giovanili all’alto livello, né l’idea che automatizzare un gesto motorio, per quanto efficace, possa facilitare l’espressione del talento.
Ericsson nel suo studio ha parlato di un certo tipo di pratica, che viene detta “deliberata” (deliberate practice) e che Anna Maria Testa, in un articolo uscito sulla rivista Internazionale (2014) ha descritto in modo molto chiaro: La pratica deliberata è qualcosa di profondamente diverso dal semplice allenamento: chiede una dose altissima di concentrazione e si focalizza non sul mantenere, ma sull’estendere costantemente le proprie capacità. Consiste nel continuare a forzare i propri limiti e nel lavorare in modo accanito sui punti deboli. Per riuscirci bisogna essere molto tenaci, molto esigenti e molto onesti con se stessi.
In termini di successo, o di buon esito del processo, la qualità della pratica è fondamentale. Deve trattarsi non di puro esercizio, non di sviluppare semplici automatismi, ma di “pratica deliberata”, ossia connotata criticamente, autodiretta: di attività che rafforzano abilità non solo specifiche, ma trasversali e quindi rafforzano le autonomie, all’interno di un sistema d’apprendimento “aperto”.
È quindi opportuno che ciascuno capisca qual è lo stile di lavoro che maggiormente si adatta al suo talento, qual è la persona, il tecnico che può accompagnarlo in questo lavoro di analisi, verifica, ricerca, e che meglio sviluppa le sue capacità.
È importante in questo senso rompere schemi consolidati, anche a livello federale, e sperimentare, assumersi responsabilità e anche sbagliare; ma non assecondare un sistema di crescita e d’allenamento che dalle categorie giovanili all’alto livello perpetua se stesso, e produce – nella migliore delle ipotesi – “buoni esecutori”, soffocando le individualità, il genio (il dáimōn, direbbero i greci) dei nostri talenti.
Questo vale per l’allenamento specifico, ma anche per l’allenamento mentale, troppo spesso inteso in senso “riparativo” (si lavora sul problema, sulla difficoltà, secondo un approccio medicale) e non positivo e preventivo – d’altronde lo psicologo, o lo psicologo dello sport e della prestazione, è un professionista che afferisce all’ambito sanitario!
È ancora troppo forte e va scardinata la divisione tra processi percettivi, motori e cognitivi, sia perché la percezione è ancorata alle dinamiche dell’azione, sia perché il cervello che agisce, è anche e soprattutto un cervello che comprende.
Il mentale nello sci alpino va quindi inteso, ripensato, proposto, non come appendice al lavoro dell’atleta, o come surrogato, ma come omologato: ciò che accade in una sfera, accade anche nell’altra, e a motivo delle stesse logiche, della stessa dinamica.
Un mentale così inteso si occupa di vissuti corporei, di esperienza incarnata (Embodiment), di “sensazione sentita” (felt sense) e muove secondo un paradigma complesso che integra quello che la psicologia divide; e utilizza quanto vi è di osservabile (la difficoltà, il problema, l’errore), per organizzare attorno ad esso una didattica dell’azione che genera comprensione.