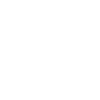Attorno al mentale nello sci alpino: una conversazione con Simone Del Dio
Ciao Simone, ti ho anticipato che il focus del ragionamento vorrebbe essere il mentale non tanto nello sport di vertice, dove a prevalere è l’aspetto prestativo, ma nelle categorie giovanili, dove è quello educativo e di crescita.
Partiamo inoltre dall’assunto che è più conveniente lavorare sulle caratteristiche della persona, in termini di consapevolezza, flessibilità, adattamenti, che non intendere l’allenamento mentale come insieme di tecniche.
Provi a descrivermi come leggi, come collochi il mentale nella tua professione?
È un po’ che non frequento le categorie giovanili, ma certamente se nel professionismo è fondamentale trovare soluzioni rapide a un determinato problema, nei ragazzi gli aspetti ludici, relazionali, aggregativi, ma anche spunti e stimoli diversi, continuano ad avere una loro rilevanza.
Non intendo dire che il lavoro sia o debba essere “meno serio”, ma certamente il risalto che viene dato al risultato, in senso strettamente cronometrico, mi sembra meno importante.
Personalmente ricerco il mentale a partire dall’aspetto tecnico, o meglio situazionale: situazioni diverse mostrano, o dovrebbero mostrare, aspetti diversi che spetta a me allenatore programmare.
Ho alcune parole chiave che per me sono: semplicità, concretezza; e se nel bimbo cerco la semplicità, non solo verbale ma nella pratica, nell’atleta cerco concretezza, nella rapidità delle soluzioni. L’atleta legge, traduce e risolve situazioni, sulla base della sua esperienza, professionalità e intelligenza.
Anzi direi intelligenze, al plurale: motoria, emotiva, spaziale, sensoriale ecc.
Per eccesso aggiungo che a me non piace usare le parole e che la situazione mi interessa più delle parole stesse. Crei una situazione, fornisci stimoli e agisci sul mentale: il mentale c’è sempre!
Sì bello questo riferimento all’intelligenza non come unica capacità generale, ma come la intende Howard Gardner quando parla di “intelligenze multiple”; ossia come differenziazione di questa caratteristica umana in modalità specifiche dell’intelligenza, che pure vanno allenate.
Visto che siamo a fine stagione agonistica, cioè in fase di riprogrammazione delle attività per atleti e organizzazioni, ti chiedo subito: che posto occupa la programmazione nel tuo lavoro? È di questi giorni la critica di De Aliprandini che lamenta un difetto di programmazione nelle squadre nazionali.
A partire da quello che ho appena detto e se il riferimento è alle categorie giovanili, non darei risalto alla quantità, che in larga misura è determinata dal contesto, dalle opportunità, dalle risorse, dal piacere dei ragazzi a fare o non fare una certa attività.
C’è una sano spirito di emulazione a volte, nei piccoli che magari hanno certi modelli in famiglia (non so, ad esempio il padre o la madre allenatori), che pure sarei per valorizzare; ma allo stesso tempo non sono per forzare il processo di crescita, che varia da bambino a bambino e da situazione a situazione.
La crescita professionale arriva dal come si fanno le cose, e non solo o non tanto dall’intensità del lavoro.
Poi oggi c’è anche una componente generazionale, culturale, che in qualche modo condiziona i risultati professionali: il futuro campione – passami il termine – è un campione “laureato”, nel senso di intelligente così come abbiamo detto sopra, e non uno che scia tanto!
Mi dici meglio cosa intendi per “qualità” dal punto di vista non solo specifico, ma sportivo in genere? Siamo qui al versante del metodo, che poi riprenderemo più avanti; dato che sono fermamente convinto che sia questo uno degli aspetti di maggiore spessore per il tecnico, ma anche per chi si occupa di educazione in ambiente sportivo e di preparazione mentale. Restiamo alle categorie giovanili.
Per me “qualità” è il modo in cui vivi l’esperienza in forma ampia.
Dirò forse una banalità ma quello che rimane, o dovrebbe restare nei giovani dell’esperienza sportiva con gli sci club, sono appunto gli aspetti legati alle amicizie, al gruppo, alla conoscenza del nuovo, le trasferte ecc.
Poi è anche l’aspetto motivazionale che passa da cose certamente secondarie, ma non per questo da demonizzare: il casco firmato dal taluno o dal talaltro atleta, il tutino figo, lo scegliere (sottolineo la parola scegliere) di stare a -10 gradi senza giacca ecc.
Non mi spaventa la parola “agonismo” e va bene il confronto con la realtà, ma vista, modulata, in base ad età e richieste.
Non è molto educativo pensare all’agonismo come risultato pubblico: in questo modo il risultato cronometrico diventa un’etichetta! A quale persona piace arrivare 10 s dietro a un’altra? Direi a nessuna! Se l’esperienza-gara si riduce a questo non è educativa e non favorisce il passaggio all’età adulta.
Ti faccio un esempio pratico: si parla tanto di multidisciplinarietà e di multilateralità. Ma se con questi termini si dovesse intendere fare dieci attività fatte in modo approssimativo, direi facciamone due, tre in modo eccellente, e perché no agonistico.
In questo modo trasferisci competenze qualitativamente alte o comunque evolute da uno sport X o Y allo sci alpino.
Mi sembra a volte, svolgendo parte del mio lavoro sul campo e a fianco degli allenatori, che spesso risulti più facile manipolare i fatti per adeguarli a una teoria, piuttosto che adattare la teoria ai fatti osservati.
Qual è il tuo rapporto con i modelli, ossia con quelle rappresentazioni che in qualche modo analizzano, studiano, permettono di comprendere ma anche riducono un fenomeno complesso? Questo sia nel mentale che nelle varie discipline legate allo sci, con un rischio di specialismo precoce.
Un modello, quale esso sia, è solo funzionale sul piano teorico e della trasmissione.
In specie nell’agonismo, l’adozione di un modello, rischia di avere una valenza estetica, ma non funzionale: un eventuale modello, per essere efficace, dovrebbe mandare veloci!
L’efficacia è il massimo del mio modello tecnico e visto che lo sci è uno sport di scivolamento, in estrema sintesi: parto dai piedi, lavoro sull’equilibrio e salgo.
Il modello deve esserci, ma deve in qualche modo emergere dalla creazione di una situazione aperta e che stimola competenze motorie e altre di tipo mentale; competenze che permettono di “imparare ad imparare”, risolvere problemi, trovare strategie e soluzioni.
Un modello o una teoria fini a se stesse non servono a molto.
Anche qui ti faccio un esempio: tutti utilizziamo video in pista e quasi ad ogni giro, già nelle categorie giovanili, si fa a posteriori l’analisi di questi video.
Innanzi tutto sono pochi quelli che la fanno contestualmente (anche per ragioni pratiche in parte comprensibili), cosa che però sarebbe opportuna, inoltre sono pochi quelli che vanno all’analisi video “sapendo cosa cercare”.
Come ti dicevo è importante creare situazioni d’allenamento dove so cosa voglio vedere dall’atleta o dal giovane atleta, per poi verificare in analisi video se quello che pensavo di ricercare è presente o meno.
Una sorta di intenzionalità di quello che intendo cercare come allenatore, e una sorta di dichiarazione d’intenti da parte dell’atleta, che poi rendono davvero utile l’analisi video come riscontro.
Questo non è un modello, ma una metodologia. Aspetto che mi sembra preponderante rispetto all’assunzione di un modello dato, per quanto valido esso possa essere.
Rimanendo al metodo, hai un orientamento chiaro sul piano comunicativo? In particolare dato oggi un certo conflitto, nello sport di base ma anche nella scuola, tra una metodologia attenta alla completezza delle informazioni (deduttiva) e una metodologia esperienziale, per prove ed errori (induttiva).
Capisco che le due metodologie si integrino e che la comunicazione in gara debba avere alcuni requisiti (essere “risolutiva”), rispetto a quella che si utilizza in fase d’apprendimento; ma ti chiedo uno sforzo d’astrazione e una tua opinione, sia per lo sport di base, che per l’alto livello, visto che non smettiamo mai d’imparare!
Come ho già detto, per eccesso, mi piacerebbe non parlare affatto in pista e fare, creare situazioni che di volta in volta destabilizzano, rafforzano abilità, ne stimolane di nuove, permettono di provare, cercare, fare errori e correggerli.
Utilizzando i feedback che abbiamo a disposizione e che sono sia di tipo interno, ossia le sensazioni dell’atleta, che esterno, il riferimento cronometrico, i video ecc.
Chiedo quindi all’atleta una certa consapevolezza e lettura di quello che fa, salvo in qualche modo “relativizzare” questa consapevolezza e lettura: la mia percezione di quello che succede nelle prime tre curve, mi dice poco o niente della qualità della prestazione.
Come dicevo, devo andare al video sapendo quello che cerco, salvo poi avere riscontri diversi che in qualche modo mettono alla prova la mia interpretazione dei fatti.
La “bomba” la metto subito! Che non significa muoversi per gradi, dal facile al difficile, ma stimolare da subito l’atleta o il giovane a trovare nuove soluzioni e adattamenti.
Lavorare nella scomodità, nella instabilità: tante volte non è una sensazione, la gratificazione, l’aspetto rilevante, ma lavorare nella instabilità, nella scomodità, intese come aree di miglioramento.
Più che un modello quindi, un metodo di lavoro, dove però cerchiamo di non standardizzare nulla, ma di differenziare, fornendo stimoli nuovi all’atleta: bisogna arrivare là, arrivaci come vuoi!
È quello che io faccio come lavoro preliminare con i giovani; ossia differenziare sensazione e percezione. Là dove la sensazione è l’informazione di base così come recepita dai nostri sensi, e la percezione è l’interpretazione, l’attribuzione di significato alle sensazioni.
È una delle cose più frequenti riscontrare un divario tra le due (il ragazzo che non ha una buona percezione di quello che ha fatto e “fa il tempo”, o viceversa) e da qui l’utilità e la complementarità, come dici te, di feedback interni ed esterni.
È chiaro che il discorso apre già all’emotivo e al “mentale”, inteso non in accezione solamente emotiva, ma conoscitiva, strategica. Ci sono aspetti che tratto con giovani atleti, allenatori, famiglie, che con estrema facilità trovano un ampio consenso, salvo poi essere puntualmente disattesi in situazione.
Solo per fare un esempio la complessità e la molteplicità di significati dell’esperienza-gara, rispetto al risultato cronometrico, comunque indicativo ma riduttivo, se assunto a parametro assoluto.
Come pensi si possa gestire, a livello di sistema, questo divario tra teoria e pratica? Che poi genera delle incongruenze interne, che a loro volta rendono poco chiari gli obiettivi, il lavoro da svolgere.
Questa è una questione ovviamente molto complessa.
Direi che abbiamo trovato questa sorta di contraddizione in ogni cosa che abbiamo detto. Per fare ancora un esempio pratico, da un lato ci diciamo a favore di un approccio esperienziale, in grado di stimolare abilità trasversali nel giovane atleta, dall’altro però sappiamo che, rispetto al modello convenzionale della progressione tecnica, i tempi d’apprendimento sono più lunghi e i rischi educativi maggiori.
Ancora, diciamo che il risultato cronometrico è relativo per i bimbi e fa più danni che altro, perché in qualche modo etichetta il ragazzino come “vincente” o “perdente”, come “competitivo” o “non competitivo”, come “bravo” o “non bravo”, dall’altro il sistema gare evidentemente premia chi vince.
Ancora una contraddizione: facciamo uno sport sensoriale, e poi diciamo che non dobbiamo fidarci molto della nostra percezione dei fatti, perché le cose non vanno proprio come noi pensiamo che vadano, sul piano dei risultati…
Ripeto che non mi spaventa la parola “agonismo” e che non ho nulla contro il cronometro, ma sottolineo solo un divario, come mondo dello sci, tra ciò che dichiariamo e quello che succede in pista. Forse è proprio una caratteristica del nostro lavoro muoverci nella contraddizione, nel disequilibrio, e in qualche modo bilanciare gli opposti!
In questo senso abbiamo grossi margini di miglioramento e di crescita, some professionisti e federazione, ma anche spazi di progettazione diversi come squadre, gruppi sportivi e sci club.
La Norvegia, che è una delle nazioni più vincenti negli sport invernali, ha un sistema in continua trasformazione e che cambia i regolamenti tecnici, sulla base dell’organizzazione sociale!
Il 93% dei bambini cresce praticando sport organizzati, i costi sono bassi, le barriere economiche in ingresso poche e gli adulti non dividono i deboli dai forti finché i bambini non sono cresciuti, non si sono sviluppati fisicamente e non hanno manifestato con chiarezza i loro interessi.
Non ci sono soluzioni facili ed è una riforma nello sport, che parte però da un cambiamento culturale e sociale!
Nota. La presente conversazione è stata articolata dando in qualche modo per assodata una certa conoscenza dell’impostazione di lavoro di Del Dio, che abbiamo provato a sintetizzare in un articolo reperibile su questo magazine e titolato: Simone Del Dio: l’azione dell’allenatore come “agire educativo” V. al link https://www.scimagazine.it/simone-del-dio-lazione-dellallenatore-come-agire-educativo/
Enrico Clementi – Educatore, Formatore, Consulente e Trainer educativo https://enricoclementi.it/
enricoclementi017@gmail.com